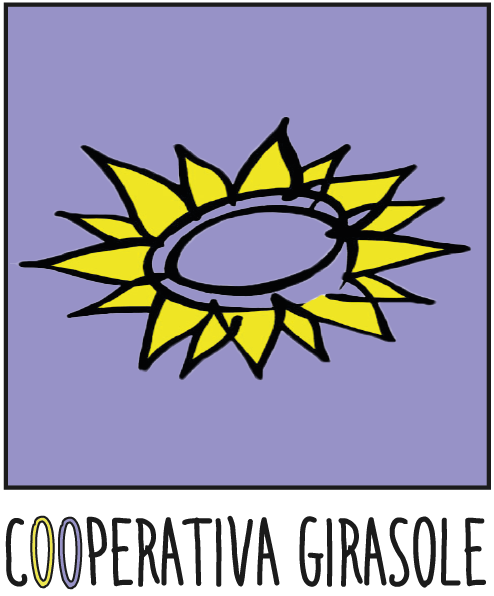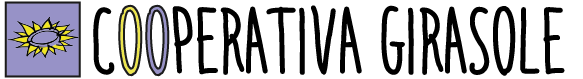Museo d’Arte Sacra
Il Museo d’Arte Sacra era in origine un convento Agostiniano del quattrocento. Accuratamente restaurato ed adibito a museo, è stato inaugurato nel giugno del 2001. E’ uno dei vari musei vicariali sorti nell’area fiorentina con il fine di aggregare beni culturali religiosi sparsi nel territorio che, per ragioni di sicurezza e custodia, non possono essere conservati nelle sedi di origine.
Il Museo conserva il patrimonio storico-artistico del Vicariato di Certaldo, delimitazione religiosa attuale che si sostituisce all’antico piviere di San Lazzaro a Lucardo, posto lungo la via Francigena, un po’ fuori dalla cittadina. Le opere provengono dalle chiese del Vicariato di Certaldo, e sono state raccolte a partire dal 1963, all’indomani della Mostra “Arte in Valdelsa”. Tale importante evento espositivo servì a mettere in evidenza l’impossibilità di ricondurre, per motivi di sicurezza, alcune delle opere esposte alle loro chiese d’origine, e la necessità di provvedere a un’adeguata conservazione museale. Il patrimonio del Museo, estremamente ricco e vario, comprende diverse tipologie di oggetti: dipinti, sculture, oreficerie e paramenti, disposti in sezioni e secondo un ordine cronologico. Il percorso di visita si propone di far conoscere un aspetto inedito, ma non per questo meno importante, della realtà culturale di Certaldo.
Sala della Compagnia della Santissima Annunziata
Ci troviamo nell’antica sede della Compagnia della Santissima Annunziata, poi del Preziosissimo Sangue di Gesù, edificata nel 1620, come attesta l’iscrizione che corre sull’architrave in pietra all’esterno della porta.
La sala si presenta con un’architettura sobria ed elegante. Sull’altare pende la tela, dalla rara iconografia, raffigurante la Madonna di Loreto tra i santi Agostiniani. Recentemente attribuito a Gabriele di Luca Grassi, questo dipinto pare possa identificarsi con quello ricordato e descritto all’inizio del Novecento su quest’altare. Ai lati sono collocati due angeli portatori di ceri e lampade votive, mentre lungo le pareti sono disposti dipinti e sculture seicentesche.
Oltre ai dipinti, tra cui l’Annunciazione, una delle tantissime copie del venerato affresco della chiesa fiorentina della Santissima Annunziata, puoi osservare le due statue lignee policrome, a grandezza naturale, raffiguranti i santi agostiniani San Nicola da Tolentino e San Giovanni da san Facondo, che in origine ornavano i loro altari nella chiesa dei Santi Jacopo e Filippo.
Opera principale: La Madonna del Rosario e Santi di Bernardino Monaldi del 1619
La tela con la Madonna del Rosario e Santi reca sul retro la firma del suo autore Bernardino Monaldi, e la data di esecuzione, 1611. Fu commissionata dalla Compagnia del Santissimo Rosario istituita nel 1579, che ebbe sede presso la chiesa di Santa Maria a Bagnano, da cui l’opera proviene. Il riferimento alla Compagnia è reso esplicito nel soggetto della tela: al centro è raffigurata la Madonna col Bambino, nell’atto di offrire il rosario a un timido San Domenico. Sopra la testa della Vergine due angioletti alati porgono una corona, mentre altri due, dalle fattezze adolescenziali, sorreggono una ghirlanda fatta di quindici grani, in allusione ai quindici misteri del rosario. A sinistra, in basso, puoi riconoscere, oltre a San Domenico, San Michele Arcangelo e un santo diacono; a destra, nel gruppo femminile, appaiono in primo piano Santa Caterina da Siena e l’elegantissima Santa Caterina d’Alessandria, immancabilmente affiancata da un frammento della ruota dentata, noto strumento del suo martirio.
Il dipinto è stato esposto alla mostra negli Stati Uniti d’America , dal titolo Picturing Mary: Woman, Mother, che si è tenuta al National Museum of Women in the Arts a Washington dal 5 dicembre 2014 al 12 aprile 2015.
Sala dei paramenti
Questa sala era in origine la vecchia sagrestia della compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù: qui sono conservati diversi paramenti sacri. Di particolare valore sono due pianete provenienti dalla chiesa di Santa Maria a Bagnano: una di epoca seicentesca a fondo avorio, con decori gialli e rosa salmone, e una pianeta del ‘700, con variopinti ricami di ispirazione orientale, che è stata sottoposta a un intervento di restauro nel corso del Novecento.
Sono esposti anche un velo omerale e un velo da calice, in un cangiante tessuto marezzato, con splendide applicazioni metalliche, e una bellissima manifattura fiorentina del XVI secolo, che rappresenta il parato in quarto, in velluto cesellato di seta a un corpo su teletta d’argento, su fondo bianco laminato d’argento e opera rossa. La tipologia, a maglie ogivali con due tipi di fiore di cardo, è ampiamente diffusa in Toscana, soprattutto nell’ambito di stretta influenza fiorentina. Forse trae origine da esemplari spagnoli, che si diffusero a Firenze probabilmente dopo l’arrivo di Eleonora di Toledo, giunta in città per andare in sposa a Cosimo I dei Medici, nel 1539.
L’ingente quantitativo di esemplari ancora oggi conservati nelle chiese del territorio testimonia il successo di questa tipologia. Sembra infatti che il motivo del fiore di cardo e della melagrana, quale simbolo di fertilità e di immortalità, si adattasse perfettamente ad ogni ambito, sia profano che religioso.
Opera principale: Il paliotto della Beata Giulia.
Il paliotto, di manifattura fiorentina è in teletta d’argento con preziosi ricami in argento con tracce d’oro. Al centro è applicata un’immagine dipinta della Beata Giulia da Certaldo.
Il termine “paliotto” deriva dal latino “pallium altaris” e durante il medioevo prese il nome di “antependium”, termine che si diffuse poi in tutta l’Europa. Poteva essere realizzato con i più svariati e pregiati materiali come il marmo, l’oro, l’argento, smalti policromi, pietre preziose e semipreziose, legno intagliato, tessuti pregiati come il lampasso, il velluto operato e broccato, il damasco di seta anche broccato in oro o argento, con ricchissimi e insoliti ricami. I cartoni solitamente venivano richiesti a pittori e scultori di primo piano. Il paliotto era al centro delle celebrazioni liturgiche, unitamente alle vesti dei celebranti e sovente abbinato a quest’ultime.
Il pregevole manufatto, di circa 62 cm di altezza, si distingue per la preziosa decorazione ricamata. Su fondo in gros de Tours di seta bianca, impreziosito da trame lanciate d’argento trafilato, puoi osservare i motivi vegetali e floreali condotti nella tecnica di applicazione. I ricami sono in altorilievo alternato a gradevoli effetti di bassorilievo con applicazioni di piccole paillettes piatte, sottili lamine di varie forme e dimensioni che compongono tralci ritorti, petali di fiori, borchie bombate che scandiscono elementi floreali e frutti dal gusto esotico.
Il disegno del ricamo è stato concepito in modo speculare intorno al medaglione centrale in taffettà di seta bianca dipinta, con l’immagine della Beata Giulia sorretta in volo da due putti alati fra nubi e raggi. Completano l’equilibrata decorazione foglie lanceolate, accartocciate e sfrangiate, perle con il profilo dentellato che si dispongono in modo armonico verso il medaglione centrale.
Un incauto intervento effettuato in anni passati ha provocato danni irreversibili al paliotto ricamato, cancellando molte tracce che potevano essere utili a individuare l’epoca di realizzazione di questo fragile manufatto.
Sala dell’oreficeria
In questa sala sono conservate una serie di croci processionali che vanno dal secolo XIII, come la Croce dell’antica chiesa Santa Maria assunta a Casale, fino al secolo XV.
Tra gli arredi più antichi potete inoltre osservare il duecentesco turibolo in bronzo di San Gaudenzio a Ruballa, le cui decorazioni a rilievo e la traforatura richiamano esemplari tedeschi; del ‘400 sono poi il calice pisside e l’ostensorio di San Lazzaro a Lucardo.
Le oreficerie barocche della stessa chiesa furono commissionate dai Gianfigliazzi. Nel gruppo degli arredi della chiesa di San Tommaso osservate anche il calice e il messale, oggetti neo gotici eseguiti specificatamente per la nuova chiesa inaugurata nella parte bassa a Certaldo nel 1885.
Opera principale: Turibolo in bronzo , San Gaudenzio a Ruballa
Sala dei reliquari
Nella Sala dei Reliquiari potete ammirare il busto della Beata Giulia, commissionato dal frate Domenico Conti, agostiniano di Santo Spirito a Firenze, e realizzato nel 1652-1653 dall’orafo fiorentino Paolo Laurentini. L’opera proviene dalla chiesa dei Santi Jacopo e Filippo ed è realizzata in argento sbalzato, cesellato e bulinato.
Il busto è impostato su una base decagonale gradinata, decorata da cartelle rettangolari; sul fronte, all’interno di una di queste, è inserita la reliquia visibile dall’esterno. La Santa è raffigurata con il velo monacale leggermente ondulato, mentre il volto segnato dall’età emerge da un soggolo fittamente pieghettato.
Sul capo è applicata una corona con palmette, finte pietre preziose e foglie d’acanto, di epoca posteriore. Il reliquiario, come racconta il canonico Malenotti autore della biografia della Beata (1819), fu eseguito per ospitare la testa di Giulia, trafugata nel 1479, dai soldati napoletani che avevano saccheggiato il castello di Certaldo e restituita al popolo certaldese soltanto sette anni più tardi. La testa però, forse per paura di ulteriori furti, fu riunita al corpo soltanto dopo il 1633, anno in cui fu abbellito l’altare della Santa nella chiesa dei Santi Jacopo e Filippo.
Opera principale: Busto della Beata Giulia,
La Pinacoteca
Siamo nell’antico refettorio del convento, con le finestre affacciate sulle mura di Certaldo; qui oggi è allestita la Pinacoteca, che vanta importanti dipinti databili dal XIII al XVI secolo. Disposte in ordine cronologico, potete ammirare le tavole che un tempo arredavano le chiese della campagna circostante.
Da Santa Maria a Bagnano, in particolare, provengono i più antichi e preziosi fondi oro: dalle maestose e solenni Madonne del Maestro del Bigallo e di Meliore entrambi capolavori del XIII secolo, al grazioso trittico attribuito alla bottega di Ugolino di Nerio.
C’è un’alternanza di dipinti fiorentini e senesi che ben si giustifica in una terra come quella di Certaldo, ai confini tra le capitali artistiche del ‘300, Siena e Firenze.
Opera principale: La Madonna in trono col Bambino e due angeli
Il dipinto di Meliore di Jacopo, detto Meliore, è databile tra il 1270 e il 1275 e proviene dalla vicina chiesa di Santa Maria a Bagnano. La tavola è caratterizzata da vivaci e intensi colori smaltati su fondo oro: la Madonna in trono presenta il Bambino, il quale con la mano destra benedice, mentre nella sinistra stringe un rotolo di pergamena.
La Vergine, coperta da un manto azzurro scuro, porta sulla testa una corona intagliata e decorata con tre cerchi in rilievo, dipinti di diversi colori; ai piedi ha delle originalissime calzature con disegni di gusto orientale. Il trono ha una decorazione geometrica nei toni rosso e blu, molto elaborata e diversa nel cuscino, dove poggia i piedi e nello schienale. In alto, ai lati del trono, due angeli sono rivolti verso la Vergine.
L’opera è in ottimo stato di conservazione: ha beneficiato di restauri conservativi solamente negli anni 1935-1936 e poi nel 1972. In occasione della mostra L’arte a Firenze nell’età di Dante, tenutasi alla Galleria dell’Accademia di Firenze nel 2004, è stata rimossa la brutta e anonima cornice: adesso, al suo posto, puoi vedere alcuni tratti della pittura originale senza che essa abbia mai subito alcun intervento di restauro. Inoltre, nella parte alta della tavola si può indovinare la forma originale della tavola stessa, dotata di una cuspide, oggi andata perduta.
Polittico di Puccio di Simone
Il percorso prosegue con esempi di pittura “primitiva”, come l’interessante polittico del giottesco Puccio di Simone, realizzato probabilmente nel 1357, al rientro dell’artista a Firenze dalle Marche. Puccio di Simone è stato uno dei maggiori artisti della seconda generazione del Trecento, capace di trasmettere elementi di novità alla pittura fiorentina. Sono esposti anche esempi di dipinti più moderni, come la Crocifissione di Cenni di Francesco o la Madonna col bambino e Santi probabilmente di Raffaello Piccinelli, dal carattere classicheggiante.
Collezione Linari
In questa sala si trovano le opere della Collezione Linari, che comprende prevalentemente tele, incisioni e un crocifisso ligneo del XVII secolo.
La Collezione proviene dalla Villa Bardi di Linari, antico borgo situato nel comune di Barberino Val d’Elsa, in provincia di Firenze, fiorente nel Medioevo, ma in anni recenti in stato di abbandono. Gli esemplari della Collezione appartennero in passato alla famiglia nobiliare Mancini, originaria di Cortona e Lucignano, in provincia di Arezzo.
Il conte Girolamo Mancini, storico, letterato, esperto di antichità ed erudito, aveva ereditato la proprietà di Linari nella seconda metà dell’800. La stessa proprietà venne successivamente acquistata dalla famiglia Dino Bardi-Manola Grassini, che risiedettero a Linari dal 1971 al 1986. Nel 2010 la collezione è passata all’erede Aloma Bardi che, insieme al marito, Gabriele Boccaccini, l’ha donata nel 2011 al Museo di Arte Sacra di Certaldo. L’esposizione è stata allestita negli anni 2011-2012. Di particolare importanza è il dipinto Mosè con le Tavole della Legge, un olio su tela di Ciro Ferri, come attesta la firma sul retro, dove è presente anche l’indicazione della data, interpretata come “1653”.
Ciro Ferri fu un significativo artista del barocco romano, illustre discepolo e quindi successore di Pietro Berrettini da Cortona. Sotto la direzione del suo maestro, Ferri realizzò dipinti al Quirinale e in Palazzo Pitti a Firenze, dove completò la Sala di Apollo e dipinse la Sala di Saturno utilizzando suoi disegni. Affrescò la cupola di S. Agnese a Piazza Navona e lavorò in altre importanti chiese romane. Se l’interpretazione della data come 1653 fosse corretta, questo Mosè risalirebbe agli anni giovanili dell’attività del pittore.
Opera principale: Mosè con le Tavole della Legge, Ciro Ferri.
Il chiostro
Tra il museo e la chiesa si trova il chiostro. Si sa molto poco sulla sua origine: il De Poveda, nel 1827, parlando della tomba del Boccaccio, ci dice che esisteva un claustrum contiguo alla chiesa dei Santi Jacopo e Filippo.
La struttura pare riferibile al tardo romanico, in una fase successiva alla realizzazione della chiesa, alla fine del XIV secolo. Il portico è stato ripristinato nel 1966 a seguito della demolizione di una cappella dedicata al culto di Beata Giulia, realizzata nel 1856, che lo tagliava in due. Il chiostro, di straordinario effetto e solennità, sfrutta la sua irregolarità a forma di trapezio per accrescere l’effetto prospettico.
Costruito su due piani è sorretto da colonne in mattoni con eleganti capitelli in pietra di notevole fattura. Sul lato più stretto si apre la porta di accesso al campanile la cui base è costruita in pietra tufacea. Dal chiostro si accede ai sotterranei del convento e alla cella di Beata Giulia dove, per sua volontà, rimase murata viva fino alla morte.
Il sotterraneo del Museo di Arte Sacra
Il sotterraneo del Museo di Arte Sacra, recentemente riportato a nuova vita, rappresenta un contributo fondamentale per capire lo sviluppo del borgo di Certaldo.
La predisposizione del sotterraneo mira non solo a mantenere intatta l’atmosfera simbolica del luogo, ma approfondisce alcune tematiche legate alla tradizione e alla cultura medievale. Nel corso dei secoli questo luogo ha subito molti cambiamenti, ma la base del muro risale alla costruzione del convento, nel XIII secolo, e la struttura dell’ambiente, con il soffitto a volta e un’ampia sala centrale completamente in pietra, ben rappresenta il tipo di costruzione medievale.
Sempre nella parte antica del muro potete osservare una particolare incisione che sembra rappresentare un calice la cui sagoma parrebbe assimilabile a suppellettili longobarde risalente all’epoca longobarda .Il sotterraneo del convento aveva una funzione particolare: esso conteneva i feretri dei monaci del convento e per questo motivo la struttura era tetramente conosciuta con l’appellativo di “Le Bare”.
La Spezieria
Nel corridoio sono esposti oggetti riguardanti l’arte della spezieria . Ogni convento disponeva di un giardino delle erbe o Hortus Conclusus, in cui venivano coltivate erbe e piante medicinali, usati per la cura dei malati ma anche per l’arte tintoria.
Qui puoi osservare alcuni esempi di contenitori utilizzati per conservare le erbe con i nomi di quelle più comunemente utilizzate; un alambicco, grazie al quale si creavano i distillati a base di erbe che venivano somministrati ai malati; un mortaio, strumento di uso comune, che serviva a triturare le sostanze utilizzate per creare i medicamenti e un calderone, usato per la cottura dei cibi o per bollire le erbe e preparare pomate e miscugli. Sono inoltre esposti utensili chirurgici (tenaglie, bisturi, seghetto, ferri per la trapanazione del cranio).
Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo
La chiesa dei Santi Jacopo e Filippo è una delle più antiche costruzioni presenti nel borgo; nel 1966 fu oggetto di un restauro radicale che l’ha riportata al suo antico aspetto medievale.
E’ in stile romanico: chiesa e complesso conventuale sorsero probabilmente verso la fine del XII secolo, contemporaneamente allo sviluppo del nucleo fortificato del paese di Certaldo. La sua antica dedicazione era ai santi Michele e Jacopo. Costruita in laterizio poggiante su una base in pietra arenaria, presenta un’unica ampia navata, conclusa da un’abside semicircolare.
L’esterno mostra alcune decorazioni in cotto, come gli archivolti delle monofore e il coronamento dell’abside a mattoni disposti a dente di sega. Al di sopra della copertura dell’abside è una finestrella cruciforme affiancata da due piccoli rombi digradanti di derivazione pisana. La porta di accesso che oggi viene usata è frutto di un intervento del 1633: prima di questa data tutta l’area della piazza era adibita a cimitero e quindi le porte di accesso alla chiesa erano quelle collocate sul fianco della chiesa stessa, che si affacciano sull’odierna via Boccaccio.
Il campanile, in linea con la facciata, presenta una copertura piramidale, frutto di un intervento di ripristino effettuato dalla Soprintendenza di Firenze negli anni sessanta del Novecento: la copertura originale era stata demolita nell’Ottocento per poter rialzare la torre campanaria, come si può vedere in alcune vecchie immagini.
All’interno, oltre a numerose opere d’arte, si trovano le spoglie mortali del grande scrittore trecentesco Giovanni Boccaccio e della Beata Giulia Della Rena, sua contemporanea e patrona di Certaldo.
In seguito ai radicali restauri promossi dalla Soprintendenza di Firenze nel corso degli anni sessanta, l’interno oggi si presenta assai spoglio, con la cortina di mattoni a vista. Durante i restauri si provvide alla demolizione della cappella dedicata alla Beata realizzata nella metà del XIX secolo situata sul lato sinistro (che ingombrava il chiostro attiguo), con il relativo tamponamento della parete; furono rimosse tutte le decorazioni neo medioevali, compreso il dipinto rappresentate il Cristo realizzato nel catino absidale forse dalla bottega di Galileo Chini, dei primi anni del Novecento; infine gran parte degli arredi subirono un riposizionamento. Il soffitto è sorretto da enormi capriate di legno.
Sotto un altare, entro una nicchia, riposano in un’urna realizzata nel 1689, le spoglie mortali della Beata Giulia: sulla mensa di questo altare è stata collocata nel 2001, in occasione dell’apertura del Museo di arte sacra, una predella del secolo XV nella quale sono raccontati i miracoli della Beata. Indubbiamente l'”inquilino” più conosciuto è Giovanni Boccaccio, il cui sepolcro è segnalato da una grande lastra marmorea pavimentale, al centro della navata, realizzata nel 1949 dallo scultore Mario Moschi, replicante con alcune varianti il famoso affresco di Andrea del Castagno facente parte della celeberrima serie di uomini illustri, oggi agli Uffizi. Il primo bozzetto di questa lastra tombale si trova esposto al piano terreno della Casa Boccaccio. In realtà le spoglie del Boccaccio non sono sotto la lastra citata, ma probabilmente sotto una piccola mattonella bianca nelle immediate vicinanze.
Il crocifisso di Petrognano
Entrati in chiesa, alzando lo sguardo in direzione dell’altare, i nostri occhi incontrano quelli spalancati, come vivi, del “Cristo di Petrognano”, straordinaria scultura scolpita nel legno che raffigura, a grandezza naturale, il Cristo crocifisso sulla croce, una croce semplice e dipinta con una cromia dai toni scuri.
Lasciamo che il nostro sguardo scorra sulla figura, dai capelli raccolti in morbide ciocche, alla bocca socchiusa, fino al torace modellato con grande attenzione al dato anatomico: con sorpresa ci accorgiamo che il Cristo, tutt’altro che bloccato nel legno in cui fu scolpito, è come animato da un soffio vitale, un moto di vita accentuato dai tratti di pennello con cui un abile pittore ha realizzato i dettagli della figura, dagli occhi ai capelli ai peli sottili di barba e baffi, questi ultimi tagliati alla “saracina”.
Il Cristo ha uno sguardo fisso e gli occhi spalancati nel suo trionfo sulla morte e i piedi non sono sovrapposti, ma separati, ognuno trafitto da un chiodo e appoggiati sul soppedaneo, all’uso bizantino, prima della riforma francescana. E’ un Cristo straordinariamente umano, come ci mostra il naturalismo con il quale è stato reso il suo corpo. La bellezza e il fascino di questa figura sono pari al mistero che avvolge le origini della scultura: il Crocifisso venne ritrovato alla fine dell’Ottocento nella piccola chiesa di San Pietro a Petrognano, sul colle dove un tempo si ergeva la città di Semifonte, anche se non era quella la collocazione originaria dell’opera. La croce è stata segata alle estremità per adattarla al piccolo edificio in cui era ospitata, ma sicuramente, viste le sue dimensioni imponenti la provenienza è da un’abbazia della zona o da una chiesa importante di un centro abitato. La critica ha assegnato il crocifisso alla seconda metà del secolo XIII.
Cella di Beata Giulia
Ulia, che una tarda tradizione scrive ai discendenti dei Della Rena, esuli a Certaldo dopo la distruzione del castello di Semifonte da parte dei Fiorentini nel 1202, nacque intorno al 1319 a Certaldo. La sua famiglia, di nobile origine, era tuttavia decaduta. Rimasta orfana in giovane età, entra al servizio dei Tinolfi nella vicina Firenze dove, venuta a contatto con gli Agostiniani di Santo Spirito e la loro spiritualità è protagonista di una singolare conversione. Sentendosi portata a una scelta di vita più radicale e austera, nel pieno fiore della sua esistenza, decide di abbandonare la città e di rifugiarsi in un luogo solitario. Torna quindi a Certaldo prendendo alloggio proprio nella stanzetta più piccola adiacente a quella dove ci troviamo.
Qui fu completamente murata salvo per due finestrelle: una corrispondente alla chiesa per assistere alle sacre funzioni e ricevere i Sacramenti, l’altra all’esterno per ricevere l’alimento che la pietà popolare le avrebbe fatto pervenire e che la reclusa contraccambiava, prodigiosamente, con profumatissimi fiori freschi in qualsiasi stagione dell’anno. Non lasciò più il suo piccolo “romitorio” fino alla fine dei suoi giorni terreni. Come le recluse, visse segregata dal mondo per un periodo di circa trent’anni, percorrendo fino in fondo la lunga via dell’ascesi. Penitenza e preghiera furono le sue occupazioni quotidiane.
A tenerla in vita pensavano i contadini di Certaldo e dei dintorni. La tradizione popolare racconta che anche i fanciulli siano corsi in suo aiuto, portandole qualche cosa da mangiare.Nulla di più si sa di lei, se non la venerazione dei suoi concittadini per la vita di pietà vissuta sotto i loro occhi. Morì una trentina d’anni più tardi, come indica la tradizione il 9 gennaio 1367. Subito dopo la sua morte a Certaldo e in tutta la Val d’ Elsa si sviluppò il suo culto.Il comune certaldese ha sempre contribuito a onorare la Beata, per intercessione della quale il paese fu più volte liberato dai contagi e dalla peste. Il suo culto venne confermato da Pio VII nel 1819, a cinquecento anni dalla sua nascita terrena. A patrocinare l’approvazione ufficiale del suo culto fu l’agostiniano Giuseppe Bartolomeo Menochio, confessore del Papa e prefetto del Sacrario Pontificio, che si interessava dei casi di antica devozione popolare.
I resti mortali della Beata Giulia si venerano nella chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, proprio nella stessa chiesa in cui un suo grande concittadino e contemporaneo, Giovanni Boccaccio, scelse di farsi seppellire. Ogni anno, la prima domenica di settembre, il paese celebra la festa della beata con una processione che dal borgo medievale si snoda fin nella parte bassa del paese per concludersi nella propositura di San Tommaso; il mercoledì successivo una processione accompagna nuovamente l’urna con i resti mortali della Beata dalla propositura fino alla chiesa dei Santi Jacopo e Filippo. Originariamente la festa veniva celebrata il 9 gennaio, il dies natalis come avviene per tutti i santi , ma a causa dei rigori dell’inverno, nel 1674 la festa venne spostata alla prima domenica di settembre, per avere un maggior concorso di persone e poter festeggiare più degnamente la santa patrona.